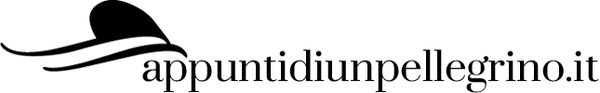Perché abbiamo fatto un Sinodo?
«Lievito di Pace e di Speranza» vuole essere la Chiesa, che è in Italia, secondo il Documento di sintesi del Cammino sinodale, approvato da un’assemblea di oltre novecento delegati, tra Vescovi, delegati delle Diocesi e invitati, dopo un percorso di quattro anni, che ha coinvolto, in diversi modi, le comunità cristiane del nostro Paese.
Questo nuovo testo è destinato alla riflessione di tutte le Chiese diocesane e di ogni battezzato, ma, di fatto, spetterà ai nostri Vescovi, che attuare e sostenere il cammino che si apre.
Ma cosa consegniamo ai nostri Vescovi?
La domanda fondamentale, ispirata alle sollecitazioni di papa Francesco e da tenere sempre presente: «in che modo le Chiese che sono in Italia possono annunciare ed essere testimoni più trasparenti del Vangelo nel cuore dell’umanità».
Sono sorpreso dalla forma con cui è posta la questione che ispira e sollecita tutto il cammino delle Chiese che sono in Italia: vi si dice “possono”. «In che modo le Chiese che sono in Italia possono annunciare» il Vangelo e «in che modo possono… essere testimoni più trasparenti del Vangelo». Ma l’annuncio del Vangelo e la sua testimonianza, secondo l’apostolo Paolo non è semplicemente una possibilità, ma una necessità.
Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: guai a me se non predicassi il vangelo! (1Cor 9,16).
Anche quel «più trasparenti» mi lascia un po’ perplesso. Non bastava dire «trasparenti»? Quante gradazioni di trasparenza possono esserci nella testimonianza del Vangelo?
Questa introduzione mi fa intuire che la Chiesa che è in Italia non sta messa tanto bene. Forse in questi anni avrebbe potuto, ma non ha voluto principalmente annunciare il Vangelo, dedicandosi ad altre attività. E, forse, in questi anni la Sua testimonianza, cioè la sua vita, non ha lasciato trasparire il volto di Cristo e il suo Vangelo, ma ancora altro.
Forse non stiamo messi tanto bene!
Le fatiche che facciamo
E infatti, il tempo di ascolto ha evidenziato diverse situazioni di fatica:
In chiesa vengono sempre meno persone, soprattutto meno giovani, per cui subentra un certo senso di frustrazione e non si riesce neanche a trovare persone per portare avanti le varie iniziative pastorali e gestire le strutture ecclesiali. Siamo sempre meno e siamo sempre i soliti.
Le famiglie non sono più luoghi adatti alla trasmissione della fede alle nuove generazioni. Eppure, le pastorali familiari ne hanno fatte di cose! Evidentemente, invece di preoccuparci di come la società civile dovesse legiferare, in questi anni, avremmo dovuto occuparci di altro, in vista dell’annuncio del Vangelo e della testimonianza della vita cristiana.
La fede non passa alle nuove generazioni anche a causa di linguaggi ecclesiali e segni liturgici che «non sembrano più intercettare l’esistenza delle persone». Facciamo i nostri discorsi e diciamo le nostre preghiere, lontani dalla vita e ignorando la realtà. Un esempio evidente mi pare l’ultima edizione italiana del Messale Romano, del quale alcuni chiedono già una revisione.
«Permangono nostalgie clericali», da parte dei preti e dei laici, di quelli che credono per inerzia, pregano per abitudine e agiscono per stare tranquilli. Insegnava papa Francesco nel 2013: «l'atteggiamento di chi si appella al "si è fatto sempre così" per mantenere pratiche e metodi che non sono più efficaci. Questa mentalità ostacola la missione evangelizzatrice della Chiesa, che necessita di audacia, creatività e un ripensamento di obiettivi, strutture e metodi, mantenendo salda la fede nel Vangelo e la dinamica missionaria». E anche il coinvolgimento delle donne nei processi direttivi e decisionali non si sente tanto bene!
«Individualismi, particolarismi e campanilismi appesantiscono spesso la vita delle comunità». Non solo siamo pochi, vecchi, spiritualmente sterili, fuori dalla realtà, ottusi, misogini, ma siamo anche litigiosi e divisi tra noi. Come notava Gesù, ci sono ancora troppi cristiani che hanno «l’intima presunzione di essere giusti», disprezzando gli altri.
Infine, «si avverte la diminuzione della rilevanza sociale della voce ecclesiale». Ma più che un segno di fatica, sembra l’esplicitazione del rimpianto nostalgico di un tempo in cui avevamo i voti necessari a influenzare le scelte politiche del Paese. Sempre secondo la domanda fondamentale dovremmo preoccuparci più se la voce ecclesiale annuncia il Vangelo, prima che se è accolta con reverenza e cordialità da parte di chi comanda. Non mi preoccuperei troppo se la Chiesa è poco ascoltata (anche Gesù non ha avuto molto successo), ma se la Sua voce lascia trasparire il Vangelo.
Cosa abbiamo imparato in questi quattro anni?
Questa accurata analisi ha suscitato alcuni «segni di risposta risposte da riconoscere, custodire e far crescere».
La priorità dell’ascolto
La priorità dell’ascolto, come dimensione essenziale della missione della Chiesa. Può sembrare paradossale, ma per comunicare efficacemente bisogna innanzitutto essere attenti ascoltatori.
Mi domando: nelle nostre comunità quanti spazi e tempi dedichiamo all’ascolto della realtà e degli altri, rispetto a tutto il resto? Quando il parroco incontra i vari gruppi, quanto tempo e con quale attitudine si mette in ascolto? E negli incontri di catechesi con i ragazzi? E in che misura, coloro che partecipano si sentono effettivamente ascoltati?
Preciso: “ascoltare” non significa semplicemente “far parlare”. Abbiamo imparato a fare “i tavoli”, ad esempio. Ci dividiamo in piccoli gruppi, alla pari, principalmente per ascoltare gli altri ed eventualmente crescere o per portare avanti i nostri discorsi e le nostre convinzioni? E poi, tutte quelle discussioni dove vanno a finire? Abbiamo la sensazione di essere ascoltati d qualcuno oppure la rassegnazione di parlare a vanvera, trasformando i tavoli di condivisione in tavoli di lamentazione.
Il valore della corresponsabilità
Necessariamente, quell’ascolto deve aprirsi al dialogo, dando spazio a nuove sperimentazioni e riconoscendo il valore della corresponsabilità, anch’essa necessaria alla vita della Chiesa.
Allo stesso tempo, è cresciuta la consapevolezza dell’importanza degli Organismi di partecipazione, non come semplici spazi consultivi, ma come strumenti concreti per il discernimento delle priorità pastorali e per il rinnovamento di strutture e processi decisionali, in una corresponsabilità differenziata, luoghi in cui lo Spirito guida la Chiesa a scelte condivise e più fedeli al Vangelo.
Significativo il fatto che i Vescovi abbiano deciso di indire una ulteriore assemblea, rispetto a quanto previsto, per discutere alcune richieste inizialmente trascurate. Dando priorità alla comprensione delle questioni, anziché centrarsi sulla risoluzione dei problemi. E si è fatta esperienza della bellezza e della fecondità del dibattito libero, del dissenso costruttivo e dello slancio profetico.
Le tensioni e gli imprevisti provvidenziali
Infine, i delegati sinodali vogliono ricordarci che lo Spirito Santo agisce come vuole, senza stare a chiederci il permesso, anche attraverso tensioni e imprevisti, che spesso ci invitano a un ulteriore e paziente ascolto della realtà, anziché correre frettolosamente a maldestri rattoppi o nell’ostinato tentativo di riempire gli otri vecchi, anziché cercarne di nuovi.
Mi pare un cambiamento di prospettiva interessante: la priorità dell’ascolto e il valore della corresponsabilità, per annunciare il vangelo al mondo, così come si presenta nella realtà, e perché Gesù Cristo possa parlare a ogni cuore, che chiede di essere accolto e non rimproverato, come fu effettivamente già il desiderio del Concilio Vaticano II.
Non siamo una organizzazione perfetta, ma una comunità di pellegrini. Non andiamo tutti d’accordo, ma viviamo la comunione. Stiamo davanti a Dio e alla storia, non come il fariseo della parabola, con la presunzione di essere i migliori del mondo, ma come grandi peccatori, che hanno sperimentato la misericordia del Signore e hanno il desiderio di raccontarlo a tutti.
E allora, per annunciare e testimoniare il Vangelo nel cuore dell’umanità, che Chiesa dobbiamo essere?